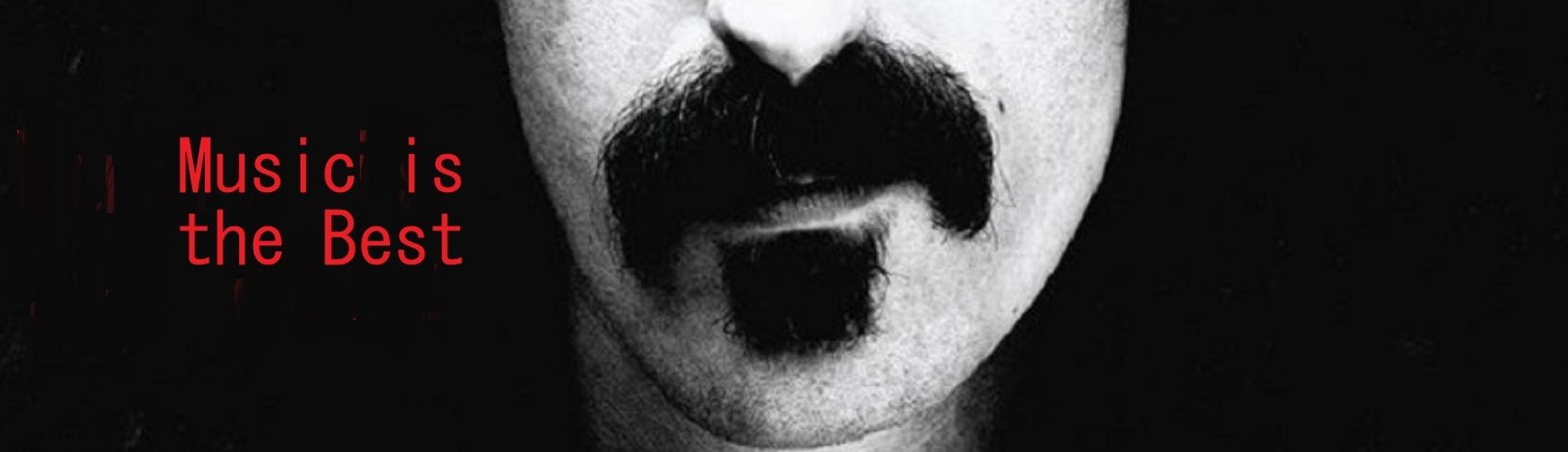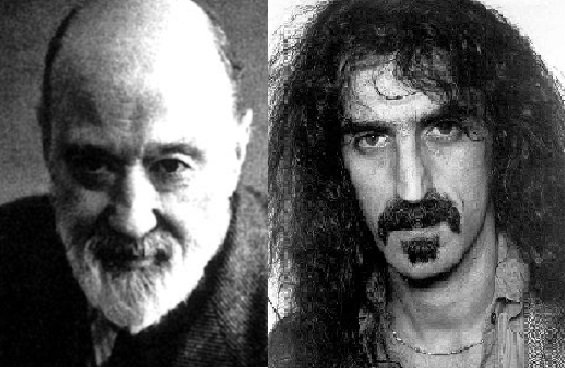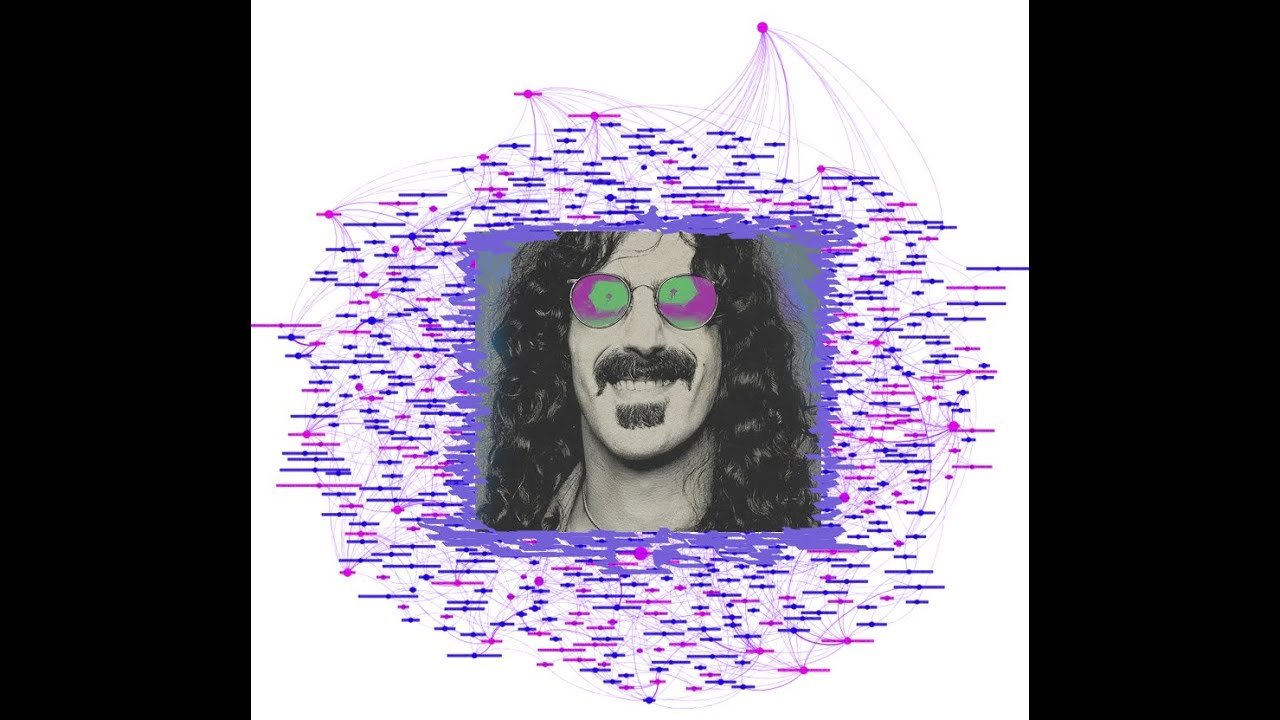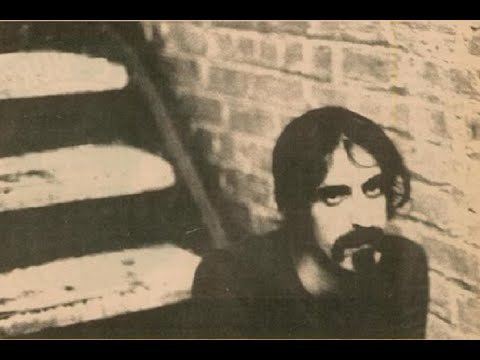Per questa xenocronia ho ‘giocato’ con alcuni brani tratti da Trout Mask Replica e da un concerto dei Mothers of Invention a The Rockpile di Toronto datato 23 febbraio 1969. Il famigerato album di Captain Beefheart & the Magic Band e il live dei Mothers sono stati registrati lo stesso anno (1969). ZAP (Zappa) & CAP (il Capitano) incontrano Charles Ives nella parte finale della xenocronia, lì dove la versione del brano “Charles Ives” (probabilmente la migliore) di Frank Zappa si fonde con quella registrata per “Trout Mask Replica” (“The Blimp” con i testi del Capitano, Don Van Vliet, cantati da Jeff Cotton).
La musica di “The Blimp” è stata composta da Frank Zappa con l’aggiunta di parole del Capitano. In sostanza, questa composizione combina una poesia di Beefheart ed un frammento di musica tratto dal brano “Charles Ives” di Zappa registrato durante un concerto.
In certi punti del Live di Toronto, gli strumenti a fiato di Zappa si sposano con quelli della Magic Band in un delirio jazz (dallo strano ‘odore’) che ricorda molto lo stile di Archie Shepp.
“Captain Beefheart e la Magic Band hanno vissuto insieme 18 mesi per realizzare ‘Trout Mask Replica’. Andavo da loro, provavano e provavano. Jeff Cotton ha preso la sua chitarra ed ha suonato le stesse 20-22 canzoni per 18 mesi. Quando sono andati a fare le tracce per ‘Trout Mask Replica’, ci hanno messo 5 ore. E’ stato necessario rifarne alcune diverse volte. Le canzoni sono state provate a morte”. (FZ, International Times, marzo 1977)
L’intero doppio album “Trout Mask Replica” è stato concepito, scritto e registrato in sole otto ore e mezza, secondo Beefheart. (Melody Maker, 8 novembre 1969)
“Trout Mask Replica ha avuto molto a che fare con il Rhythm & Blues. Quello che Beefheart stava realizzando derivava molto da Muddy Waters e Howlin’ Wolf. Ma pochissimi di loro l’hanno capito, men che meno le ragazzine di 13 anni che sono quelle che comprano più dischi. ‘Ragazze carine, comprate dischi di cantanti che sembrano bei ragazzi’: è così che funziona l’intero business del pop!”. (FZ, Stereo, gennaio 1985 – rivista tedesca)
“Realizzare Trout Mask Replica è stato molto difficile perché Captain Beefheart non si trova a suo agio con la tecnica in studio. Ad esempio, a Don non piacevano gli auricolari. Quindi, quando si è trattato di aggiungere la sua voce, quello che voleva fare era stare in studio e sentire la traccia che filtrava attraverso la finestra – quindi, cantare più forte che poteva sopra di essa. Il guaio è che la sua voce rischiava di non essere sempre sincronizzata con la traccia che Don riusciva a malapena a sentire dalla finestra. Ma voleva lavorare così. Non è un modo semplice per mettere insieme un album”. (da un’intervista a FZ del 1991 pubblicata su Mojo novembre 2018)
“Dopo quattro anni di assenza, il Capitano ha chiamato a casa 3-4 settimane fa, di punto in bianco. Ha chiesto di me ma io non c’ero, così ha parlato con Gail per un po’. Gail gli ha chiesto cosa volesse e lui ha risposto: “Ho chiamato Frank per ringraziarlo di aver prodotto l’album Trout Mask Replica. È il miglior album che abbiamo mai pubblicato.’ “. (FZ, Exit, maggio 1974)
“Ci sono cose incredibili su Trout Mask Replica e anche su Clear Spot. C’è dell’altro del periodo Trout Mask. Non so se uscirà mai. C’erano cose nelle sessioni originali che Don non voleva usare. Il piano originale per l’album era di farlo come una registrazione sul campo etnico. Lui e il suo gruppo vivevano in una casa nella San Fernando Valley, quindi volevo prendere un rig portatile e registrare la band in casa, usare le diverse stanze della casa come isolamento molto leggero con voce registrata in bagno, i tamburi nel soggiorno, il corno in giardino, ecc. L’abbiamo impostato e abbiamo fatto le tracce in quel modo… Ero in studio a mixare altri nastri. La band che suona su The Blimp, in realtà, è quella dei Mothers. La parte vocale del brano è stata registrata per telefono. Captain Beefheart aveva appena scritto questo testo e l’ha fatto recitare al telefono da uno dei ragazzi della sua band. L’ho registrato in studio sul pezzo di nastro che avevo in quel momento, ovvero la mia traccia. Ecco com’è andata… Il ragazzo che recitava le parole era Jeff Cotton (alias Antennae Jimmy Semens, come era conosciuto all’epoca). The Blimp è incluso col titolo di Charles Ives in un episodio di You Can’t Do That On Stage Anymore. Suonavamo il pezzo nel tour ’68-’69”. (Best of Guitar Player, 1994)